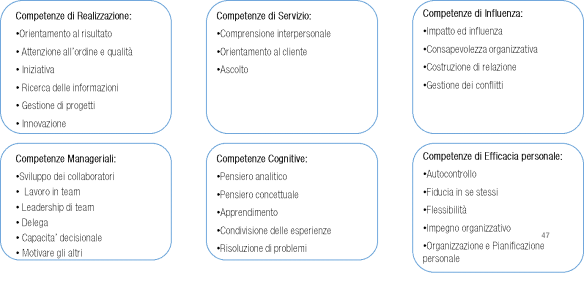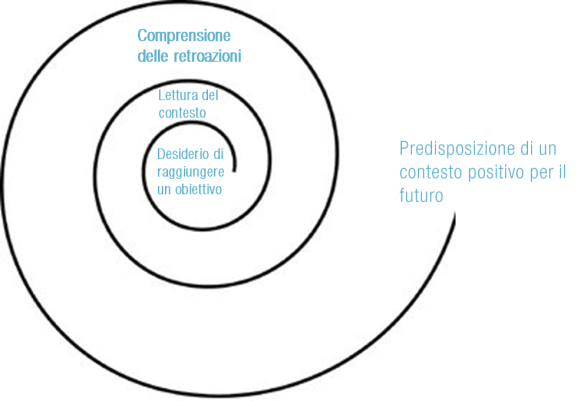Oggi siamo più intelligenti rispetto a cinquant’anni fa?
Oggi siamo più intelligenti rispetto a cinquant’anni fa?
Sembrerebbe di sì. James Flynn, Professore emerito di scienze politiche presso l’Università di Otago, in un suo celebre studio sull’intelligenza ci informa che il QI tende a crescere di circa 9 punti ogni generazione. Rispetto al secolo scorso quindi, il QI medio della popolazione è aumentato di circa 30 punti.
Associo a questa ricerca un altro dato interessante: il Report Training Industry Research 2019 ci dice che nel corso del 2018 le aziende hanno speso complessivamente 3,4 miliardi di dollari in programmi di sviluppo della leadership ed evidenzia un trend in forte crescita.
Ebbene, possiamo affermare che questo aumento del QI si sia tradotto in scelte e decisioni migliori rispetto al passato? Nello stesso modo possiamo considerare i leader di oggi migliori di quelli di ieri? Si avverte, insomma, nel mondo questa crescita di leadership e di intelligenza?
Leggendo le news sui giornali, le statistiche internazionali e, soprattutto, dando un’occhiata a quanto accade sui principali social, dubito che si possa pensare che il mondo vada nella giusta direzione. La crisi finanziaria dello scorso decennio ha accresciuto le diseguaglianze economiche e sociali, in diverse parti del mondo sono arrivati al potere leader illiberali alla guida di movimenti populisti, si diffondono sentimenti di intolleranza razziale e religiosa spesso alimentati dal fenomeno delle fake news e ci troviamo di fronte ad una preoccupante crisi climatica a cui nessuno presta davvero attenzione.
Anche all’interno delle organizzazioni non si vedono effetti positivi. La vita media delle aziende si è dimezzata rispetto agli anni ‘90 e le survey internazionali sul clima organizzativo segnalano una costante disaffezione dei lavoratori nei confronti delle imprese, registrando livelli di engagement in drastica riduzione.
Robert J, Sternberg, docente di Human Development presso la Cornell University e autore del recente “The Cambridge Handbook of Wisdom” (2019), sembra avere le idee chiare sulle cause che hanno portato a questa situazione: «The world is not suffering from a lack of intelligence or leadership, it is suffering greatly from a lack of wisdom.” Siamo quindi più intelligenti, ci atteggiamo a leader ma manchiamo completamente di saggezza.
Si parla di saggezza dai tempi di Socrate, ma le ricerche accademiche nel campo della psicologia, sociologia, filosofia ed antropologia sono piuttosto recenti. La definizione di saggezza che scaturisce da questi studi è particolarmente interessante: viene considerata come l’arte di raggiungere un bene comune trovando un equilibrio e un bilanciamento tra interessi diversi (intra, inter ed extrapersonali) e tempi (effetti di breve e di lungo termine), collocando la propria azione/decisione all’interno di un contesto (comprendendolo, adeguandosi e plasmandolo nel tempo).
Vi sono tre aspetti che rendono il concetto di saggezza particolarmente interessante per il mondo di oggi: 1) si focalizza sul “bene comune”, 2) rappresenta la capacità di gestire con efficacia i trade-off (breve e lungo termine, interessi personali, del gruppo di appartenenza e della comunità allargata) e 3) si radica profondamente al contesto in cui si agisce. La saggezza non porta quindi con sé modelli di azione preconfezionati o protocolli standardizzati a molti tipi diversi di problemi. Al contrario, rappresenta la capacità di comprendere il carattere specifico di luoghi, persone e momenti particolari, consentendo di individuare l’azione e la decisione più efficace per il bene comune.
Osservando le vicende internazionali e le modalità di gestione di molte aziende, è impossibile non notare una significativa mancanza di saggezza. Vincono egoismi e localismi, il raggiungimento di obiettivi di breve, la creazione di nemici esterni come modalità identitaria, il narcisismo dell’ego che mette al centro l’interesse individuale e la logica della vittoria a tutti i costi. L’ottica di massimizzazione del profitto/valore, la deificazione dei CEO così come il proliferare dei guru, ne rappresentano gli effetti nel mondo aziendale.
La saggezza è sempre stata una componente importante per l’umanità, ma oggi siamo di fronte ad una situazione più pericolosa. In epoche passate ci si poteva affidare ai “saggi”, figure mitiche quanto rare che dispensavano consigli e guidavano gli altri. Oggi tutto ciò non è più sufficiente. Il mondo di oggi è fortemente interconnesso e interdipendente. Questa complessità porta ogni individuo (secondo i suoi gradi di responsabilità) costantemente ad affrontare trade-off, imprevisti, ambiguità e paradossi. E le sue scelte possono avere effetti sistemici per tutta la comunità in cui opera. L’insipienza e la miopia delle scelte individuali, a tutti i livelli, può quindi determinare l’insorgere di conseguenze non solo locali (vicine al decisore) ma anche globali.
Per affrontare questo contesto il QI non è sufficiente. Così come non è sufficiente un tradizionale approccio alla leadership. Il leader carismatico, che indica la strada da seguire, crea seguaci e fornisce certezze agli altri, può infatti determinare un abbassamento del pensiero critico, dell’originalità e della propensione delle persone a comprendere il contesto in cui si stanno muovendo. In sintesi, la leadership può crescere a discapito della saggezza.
Se vogliamo continuare a parlare e ad investire sulla leadership occorre ripensarne i concetti dalle fondamenta. In un mondo interdipendente e ricco di trade off, una leadership efficace non può focalizzarsi su obiettivi locali/particolari perdendo di vista il concetto di bene comune nella comunità all’interno della quale si esercita. Nello stesso modo, non può più essere monodimensionale, basata sul carattere e sui comportamenti di un leader che crea follower.
La leadership deve diventare “wise leadership”, radicata quindi sulla comprensione del contesto, centrata sulla capacità di gestire i trade-off, orientata al bene comune e fondata più sull’equilibrio che sull’ego del leader.
Ci sono molti passi da fare per andare in questa direzione. Il primo non può che essere rappresentato dall’educazione delle nuove generazioni. Come infatti sottolinea Sternberg: “the greatest problem today is not reading or math – it is the failure to teach students to think wisely and well”.
(articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore il 17 luglio 2019https://www.ilsole24ore.com/art/piu-che-leadership-abbiamo-bisogno-saggezza-ACBEz3M?refresh_ce=1 )





 Qual è lo scopo di un manager nei confronti del proprio team? Si prendano ad esempio queste due differenti interpretazioni (Figura 1).
Qual è lo scopo di un manager nei confronti del proprio team? Si prendano ad esempio queste due differenti interpretazioni (Figura 1).